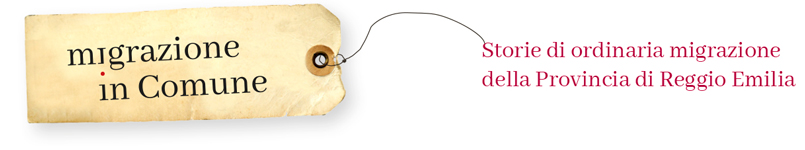Intervista raccolta nel 2021 da Chiara Torcianti
Il colonialismo italiano, come noto, affondava le sue radici nei primi decenni post-unitari e, nonostante la disfatta di Adua del 1896, aveva continuato ad affermarsi in età giolittiana, per poi essere progressivamente incastonato nella prassi e nell’ideologia del regime fascista. A strappare dalla madrepatria tanto la Libia quanto Eritrea e Somalia ci occupò la seconda guerra mondiale, tra il 1941 e il 1943. Senza contare che l’imperatore Haile Selassie rientrò solennemente ad Addis Abeba, con l’appoggio degli inglesi, esattamente cinque anni dopo la brutale conquista del regno etiopico da parte delle truppe italiane comandate da Graziani e Badoglio.
E la repubblica quale posizione tenne nei confronti delle ormai ex colonie? A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, l’articolata lobby coloniale, che univa pezzi delle istituzioni centrali dello stato e grandi interessi industriali e militari, non si arrendeva al progressivo affermarsi, nella coscienza pubblica italiana e nelle istituzioni internazionali, del principio di autodeterminazione dei popoli applicato anche ai cittadini dei cosiddetti ex possedimenti d’oltremare. Il trattato di pace, siglato a Parigi il 10 febbraio 1947, di fatto esautorava l’Italia dal ruolo di “accompagnatore” delle ex colonie verso l’indipendenza, affidandolo alle Nazioni Unite. Attenzione, però: secondo alcuni storici, tra cui Antonio Morone, proprio questa sorta di decolonizzazione dall’alto ha alimentato un doppio corto circuito all’interno della società e della politica italiane. Innanzitutto, essa ha consentito a questa giovane democrazia e ai suoi cittadini di evitare il confronto con le esigenze e le necessità di popoli in lotta per la propria indipendenza. In tal modo, nessuna vera presa di coscienza critica rispetto al proprio passato coloniale ha potuto davvero attecchire in profondità e diffusamente nel corpo sociale della nazione. Inoltre, come già accennato, quei soggetti ed enti che avevano in qualunque modo tratto vantaggio dalle colonie tentavano di nutrire consenso culturale attorno alle proprie posizioni neoliberiste e decisamente poco in sintonia con le strategie promosse dalle Nazioni Unite e dalle rappresentanze degli aspiranti paesi nuovi.
A cavallo tra la fine degli anni quaranta e cinquanta, infine, mentre la Libia acquisiva l’indipendenza e l’Eritrea era vincolata ad una improbabile federazione con l’Etiopia, i cosiddetti “africani d’Italia” erano trattati da clandestini sul suolo di quella che, per molti di loro, restava ancora la madrepatria. Perciò, d’altro canto, se il governo italiano si prendeva in carico l’Amministrazione fiduciaria della Somalia (1950-1960), sotto stretta egida Onu, l’idea di italianità restava ancorata ad una visione razzialmente omogenea e territorialmente definita. Insomma, sin dai primi passi della nostra repubblica, non vi fu posto per quegli eritrei, somali o libici che si definivano italiani e che, con la loro stessa presenza, mettevano in discussione un prototipo di identità terrorizzata dalla complessità e astratta dal flusso della storia.