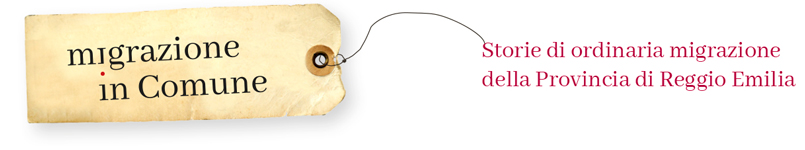Intervista raccolta nel 2020
Lingua
La lingua che si impara in famiglia e nella comunità, non a caso è detta madrelingua, poiché porta con sé l’imprinting della forma mentale e della codificazione delle emozioni, trasmette valori e disciplina il corpo. C’è tutto l’affascinante comparto della comunicazione non verbale, infatti, ad accompagnare l’espressione linguistica, come gli stereotipi sugli italiani all’estero (più o meno generalizzabili o pertinenti) dimostrano chiaramente.
Secondo i sociolinguisti contemporanei, l’autentica padronanza di una lingua si manifesta nel discorso, ovvero nel suo uso pratico e relazionale. Se una lingua è portatrice di universi culturali e simbolici, allora è nella sua fruizione che la negoziazione di significato con altri esseri umani può avere luogo. Detto altrimenti: è il piano della comunicazione che qualifica il rapporto di un soggetto con la lingua d’origine e con quella della società di approdo. La lingua è, al contempo, anche supremo simbolo di alterità, quindi e non solo quando priva il soggetto “foresto” di immediati appigli di comprensione. Eppure, spesso, capita che proprio questa sorta di spaesamento linguistico consenta al migrante lo spazio di manovra necessario per reinventarsi, tanto sul piano personale quanto su quello lavorativo e civico.
Una lingua è simile ad un essere vivente. Essa è frutto di una storia articolata, è stata plasmata tanto dai grandi eventi che hanno impattato sui popoli, quanto dalle esigenze quotidiane di persone comuni che, letteralmente, masticandola l’hanno modificata. Giusto per fare un paragone: questo fenomeno ricorda un po’ quanto lo storico Braudel sosteneva riguardo ai commerci nel Mediterraneo nel XVI secolo. Ovvero che per comprenderli bisogna, certo analizzare la politica dell’impero spagnolo, ma anche mettersi in cammino nei bazar, nei mercati e nei porti del mare nostrum e osservare i gesti minuti e ripetuti dei commercianti e dei compratori.
D’altro canto, identificare un gruppo linguistico con un idioma d’origine omogeneo e ben definito, a volte risulta essere un’operazione azzardata rispetto alle storie che l’hanno intessuta. Per esempio, gli italiani che cominciarono ad arrivare a Brooklin sin dagli anni ottanta dell’Ottocento, portarono con sé i loro dialetti, piuttosto che l’italiano – che, all’epoca, era la lingua nazionale delle classi sociali più elevate, non certo della gente comune. Da qui, il cosiddetto italianese parlato dalle successive generazioni di italoamericani, fenomeno noto al grande pubblico soprattutto grazie al cinema.
Per soffermarci sui contesti di arrivo: sicuramente le affinità o parziale coincidenza tra le due lingue (quella originaria e quella del luogo di arrivo), influisce sulla scelta soggettiva della meta finale di un percorso migratorio. Questo processo ha avuto luogo, per esempio, quando molti abitanti delle ex colonie africane e asiatiche si sono trasferiti nelle città degli ex-imperi, a partire dagli anni sessanta del secolo scorso. Ho sottolineato “parziale”, perché le lingue europee parlate in Africa assumono spesso connotazioni sintattiche, semantiche e lessicali ben precise, che le distinguono nettamente rispetto alle forme linguistiche tipiche della vecchia madrepatria coloniale, proprio grazie all’ interpretazione subita da queste ultime in un contesto “altro”. Eppure, anche in questo campo, sarebbe fuorviante generalizzare. Sulla minore o maggiore capacità di apprendimento della lingua della società di arrivo e quindi sul processo di integrazione tout court, incidono sempre due serie di fattori. Quelli legati alla società di accoglienza, che potremmo definire strutturali – e ad una molteplicità di variabili personali, tra i quali le scelte, le predisposizioni, i progetti, i talenti, le competenze che ciascuna persona che migra reca con sé.