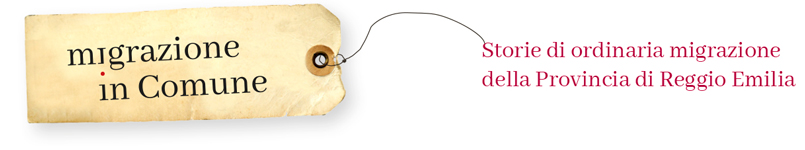Intervista raccolta nel 2020
L’Italia e i beni culturali
Se in Italia venisse applicata alla lettera la convenzione Onu per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato (firmata all’Aya, nel 1954), la mappa del nostro paese risulterebbe, più che punteggiata, ricoperta da macchie pressoché uniformi di bianco e blu. Infatti, sono questi i colori dell’emblema di protezione associato alla convenzione, ovvero la cosiddetta croce di sant’Andrea. Il nostro paese giocò un ruolo chiave nell’elaborazione di questo strumento giuridico internazionale. La seconda guerra mondiale aveva spazzato via molte vite, segnando inesorabilmente l’esistenza di chi era sopravvissuto. I bombardamenti avevano cominciato a piovere sui grandi e medi centri urbani sin dall’estate del 1940 e, messa a repentaglio, non era soltanto la popolazione civile, ma anche il patrimonio artistico e culturale stratificato nei territori nel corso dei secoli.
Cosa sarebbe l’Italia senza quella molteplicità dei beni culturali, che, nei piccoli centri come nelle grandi città, incarnano il senso stesso di identità di lungo periodo eppure sempre in movimento? Domanda banale, forse. Eppure non così tanto se, ancora in questi anni, nonostante l’Unesco abbia sinora riconosciuto dal 1972 all’Italia ben 55 siti quali patrimonio dell’umanità (nessun paese ne conta altrettanti), fatichi ad affermarsi l’idea che il settore culturale possa anche, più prosaicamente, generare posti di lavoro e contribuire al Pil nazionale. Eppure, per quanto riguarda il prodotto interno lordo dell’Unione Europea, il comparto culturale gioca un peso pari al 4% – mentre, nell’anno precedente lo scoppio della pandemia, questo settore composito incideva di oltre il 6% su quello italiano. I dati, sino al 2019, permettevano di rilevare un incremento netto sia degli occupati che del valore aggiunto generato.
Al di là delle considerazioni di carattere economico, forse il vero paradosso dell’approccio ambivalente che il nostro paese nutre rispetto al proprio patrimonio culturale e ambientale giace nell’incapacità del mercato del lavoro di assorbire e di avvalersi di quelle figure specializzate che, spesso, dopo aver fatto i primi passi in Italia, vanno a perfezionarsi e a spendere la propria professionalità in altri del globo. Lungi da me sciorinare la litania della “fuga dei cervelli”, definizione che copre una molteplicità di processi e fenomeni più articolati.
Piuttosto che fornire risposte delle quali sono sprovvista, preferirei invece concludere con una storia. Straordinaria ed esemplare, al tempo stesso, nel suo mostrare i valori profondi insiti nel porre al centro di una società i beni culturali. Fernanda Wittgens, milanese, classe 1903, laureata in storia dell’arte, approdò alla Pinacoteca di Brera come operaia avventizia. Competente, generosa e appassionata, Fernanda si conquistò sul campo il ruolo del braccio destro del direttore, l’italiano di origini ebraiche Ettore Modigliani. Insieme a lui imparò a gestire una così prestigiosa istituzione, almeno fino al 1939 quando, a causa delle leggi razziali, Modigliani fu cacciato dalla Pinacoteca. Nel 1940, con l’imminente entrata in guerra dell’Italia, la Wittgens vinse il concorso, divenendo la prima direttrice donna di un istituto culturale di tale livello, mentre il suo predecessore fu costretto a fuggire con la sua famiglia per eludere le maglie della persecuzione. Fernanda capì subito che il conflitto non avrebbe risparmiato nemmeno i capolavori di Brera e si attivò per metterli in salvo, non tirandosi indietro nemmeno di fronte a disagevoli viaggi in camion pur di portarli in luoghi sicuri, sparsi nelle campagne lombarde. Accanto all’arte, tuttavia, aiutò anche gli esseri umani, mettendo in salvo ebrei e prigionieri alleati, supportando la resistenza, insieme ad una rete in cui le donne giocarono un ruolo essenziale. Il suo impegno, però, lo pagò con sette mesi di carcere. A conflitto finito, la Wittgens chiese aiuto al primo sindaco democratico di Milano affinché fosse ripristinato il complesso di Brera e Greppi capì che non era una richiesta assurda, quella formulata dalla direttrice. Per rialzarsi, la città e il paese tutto non potevano prescindere dal recupero e dalla valorizzazione dei loro tesori storico-artistici. Nella consapevolezza che questi ultimi sono frammenti di una eredità insostituibile, che una generazione riceve da quelle precedenti e che si impegna a trasmettere a quelle che verranno.