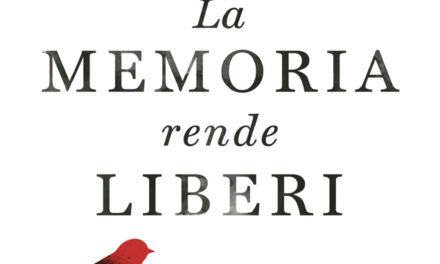«Questa non è la Storia. Questa è una storia… È la storia di un uomo che non c’è più. Ma è più mia di qualunque altra storia mi venga in mente in questo momento. Quindi è quella giusta».
Sono parole di Adelmo, figlio dell’Aldo Cervi ribelle e anticonformista entrato nella leggenda della Resistenza insieme ai fratelli. «Sono figlio di un mito» sostiene Adelmo Cervi nel suo libro «Io che conosco il tuo cuore» (Edizioni Piemme, 2014), scritto insieme a Giovanni Zucca, nel cui sottotitolo viene esposto con maggiore precisione l’intento: «Storia di un padre partigiano raccontata da un figlio». Non la Storia dunque, ma una storia, quella di Aldo, simbolicamente racchiusa, in apertura al volume, tra due foto: la prima di fine anni Trenta, con la famiglia al completo composta dai genitori e dai sette fratelli; la seconda, dopo la Liberazione, con il vuoto lasciato dai fratelli uccisi dai fascisti (28 dicembre 1943) colmato dai loro figli, uno dei quali, Adelmo, è seduto sulle ginocchia del nonno Alcide. Non è facile affrontare un simile argomento per chi, a pochi mesi dalla nascita, ha perso il genitore, e lo è ancor più nel caso in cui lo scomparso sia stato sottratto alla dimensione affettiva e consegnato alla leggenda. «Perché portare sulle spalle e dentro la testa questa storia – non ti offendere se te lo dico – è un peso della Madonna, è una responsabilità, è un lavoro, un obbligo, una catena» confessa il figlio nel suo dialogo immaginario con Aldo, ed è per ritrovare la figura paterna nella dimensione individuale e sentimentale che l’autore intraprende un lungo viaggio, per staccare dalla Storia e dal marmo del monumento costruito sulla famiglia un’immagine più autentica, soggettiva: «E io volevo sapere lui com’era, e ogni tanto glielo chiedevo, magari di notte in sogno».
Chi conosce Adelmo ha la netta impressione che l’irrequietezza, la curiosità, l’anticonformismo, il carattere sanguigno, uniti all’impegno d’essere coerenti nelle proprie scelte, siano un’eredità paterna, ed il testo di «Io che conosco il tuo cuore» pare confermare tale opinione: «Siamo sempre stati strani, noi Cervi… Strani, matti, ribelli, che fosse da una parte o dall’altra, comunque sempre a combattere per qualcosa» scrive infatti Adelmo, che in un altro passaggio è ancora più esplicito: «Mi dicono che non eri tanto alto, ma neanche basso. Che parlavi sempre (e qui mi riconosco) con una voce acuta, che quasi pungeva. Che andavi avanti e indietro come un matto in bicicletta… Da un pero non nasce un melo, dicono, e le migliaia di chilometri che ho incamerato nei polpacci dimostrano che è vero». In questa interiorizzazione della storia paterna l’autore è quasi obbligato, come si diceva, ad affrontare il mito costruito con grande cura, negli anni successivi alla liberazione, dal Partito comunista con il determinante contributo di intellettuali come Calvino e Quasimodo, e dal testo più conosciuto, curato da Renato Nicolai, ricavato dalle testimonianze dell’icona familiare, Alcide, il papà Cervi di I miei sette figli (Einaudi, 2010), pubblicato per la prima volta nel 1955. Quella leggenda, indagata inizialmente da Eva Lucenti in I fratelli Cervi, nascita di un mito (Annali dell’Istituto Alcide Cervi, 2006), successivamente ripresa e approfondita da Marco Cerri in Papà Cervi e i suoi sette figli. Parole della storia e figure del mito (Rubbettino, 2013), costringe Adelmo ad intraprendere un’azione di rottura per recuperare una visione più genuina del padre e dell’intera famiglia: «Mi è difficile ogni tanto distinguere i fatti dai racconti, quello che ho sentito dire da quello che io stesso mi sono detto di tutta questa storia, dal senso che io stesso ho voluto dare, con la mia vita, in prima persona, perché ne avevo bisogno». In questo tentativo l’autore afferma non solo che «…a dire la verità un po’ce l’avrei anche su, con questo mito, perché si è portato via mio padre», ma prende pure le distanze dal testo storico di Alcide (I miei sette figli) per dire che Aldo «più che un uomo è stato … una parte di un raccolto, che dopo ne doveva venire un altro, come diceva il nonno, e così è stato. Ma gli uomini non sono spighe di grano … e non è vero che uno vale l’altro», giungendo infine allo strappo definitivo: «vorrei una tomba normale con scritto Aldo Cervi, 1909-2001, tanto per farti arrivare a questo secolo. E in cambio darei indietro le strade e le piazze con i vostri nomi: si può dire, questo, senza che sia considerata una bestemmia?». Per tale percorso di riappropriazione Adelmo utilizza gli strumenti del dialogo, con se stesso e col genitore, e del viaggio sia temporale che geografico, in vicende e ambienti legati ad Aldo e alla famiglia, dalla casa dei Campi Rossi di Gattatico (divenuta dapprima luogo di innovazione nelle tecniche agricole, poi punto di riferimento per la lotta antifascista e per l’accoglienza di rifugiati politici ed ex prigionieri, infine museo), agli itinerari della banda partigiana, tra la pianura e la montagna, sino all’epilogo tragico nel dicembre del 1943. Non si tratta di un’impresa facile per l’autore, costretto a scavare negli eventi, nei sentimenti e nella propria identità: «Che strana posizione, quella da dove guardo la tua storia, papà. E che razza di personaggio mi sono ritrovato a interpretare! Quello di un bambino che ancora non sa niente, chiuso nel corpo di un uomo vecchio che sa anche troppo. O forse è il contrario, non so più bene. È difficile capire con precisione dove sto e chi sono».
L’originalità di Io che conosco il tuo cuore è costituita da diversi aspetti intrecciati fra loro: memoria e letteratura. Ai differenti livelli, storico da un lato e biografico-narrativo dall’altro, si aggiunge la dimensione di un percorso interiore che ha affinità con il bildungsroman (romanzo di formazione), al termine del quale il protagonista, Adelmo, acquisisce una nuova consapevolezza. Un particolare merito è senz’altro da attribuire al coautore, Giovanni Zucca, il quale ha saputo organizzare una notevole quantità di materiali (testi, documenti, testimonianze personali) dando ad essa, attraverso dialoghi, racconti e introspezioni, struttura narrativa e spessore letterario, senza mai perdere di vista la fedeltà ai fatti. In tal modo, con una scrittura scorrevole e immediata, la lettura diviene avvincente anche grazie alla capacità, da parte di Adelmo, di comunicare, sicuramente ereditata da Aldo. Questo suo lungo viaggio alla ricerca del padre si conclude con una presa di coscienza definitiva, maturata nella residenza storica di famiglia, a Gattatico, in «quella cosa di nome «museo», che si sta mangiando la casa … da cui piano piano – gentilmente, ma non troppo – il mito ti sta cacciando via. Ci vuole tempo per accettarlo. Ce ne ho messo di tempo. Per capire, per capire davvero. Col cuore».
Giovanni Guidotti